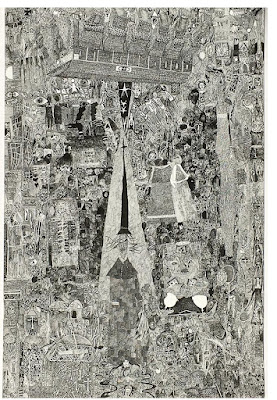Uno dei capolavori degli anni novanta è "Goat", il secondo Lp dei Jesus Lizard di Chicago. Un lavoro che merita di essere ricordato come uno dei dischi più viscerali di tutti i tempi, anche a prescindere dal peso non indifferente che ha esercitato sulla scena post-hardcore e noise.
Noise, ma a modo loro. Due dei quattro si erano fatti le ossa negli Scratch Acid, e ciò è contato molto nella definizione del suono dei Jesus Lizard, che con le canzoni di "Goat" portarono ai massimi livelli la fusione di melodie roots e rumorismo noise-rock, sia nella musica che nell'immaginario. Qualcosa di simile l'aveva fatto Steve Albini nei suoi testi, mentre per quanto riguarda la musica il la l'avevano dato dieci anni prima i Birthday Party, col loro post-punk blueseggiante. I Jesus Lizard però si spinsero oltre, generando un caso alquanto unico nel rock.
 Tre strumentisti eccezionali e peculiari suonano ritmiche e tessiture intricatissime. Poi, il più sgraziato dei cantanti gode nello scombinare tutto. E' David Yow, vero maestro nell'usare la sua voce tecnicamente scarsa in modo espressionista e poco ortodosso. Urla, ringhi, conati, versacci, ogni mezzo è lecito per suscitare disagio in chi ascolta, shockarlo, trasmettergli con crudo cinismo quel senso di degrado, violenza psicologica e disaffezione. Ma ogni cosa è studiata al suo posto con chirurgica precisione, dai ragli di Yow ai tempi dispari della batteria di Mac MacNeilly e, dulcis in fundo, l'ottima produzione di Steve Albini rende il tutto ancora più claustrofobico e dannatamente perfetto.
Tre strumentisti eccezionali e peculiari suonano ritmiche e tessiture intricatissime. Poi, il più sgraziato dei cantanti gode nello scombinare tutto. E' David Yow, vero maestro nell'usare la sua voce tecnicamente scarsa in modo espressionista e poco ortodosso. Urla, ringhi, conati, versacci, ogni mezzo è lecito per suscitare disagio in chi ascolta, shockarlo, trasmettergli con crudo cinismo quel senso di degrado, violenza psicologica e disaffezione. Ma ogni cosa è studiata al suo posto con chirurgica precisione, dai ragli di Yow ai tempi dispari della batteria di Mac MacNeilly e, dulcis in fundo, l'ottima produzione di Steve Albini rende il tutto ancora più claustrofobico e dannatamente perfetto.
 I nove brani - perfetti dal primo all'ultimo - sono molto omogenei tra loro, ma colmi di variazioni: blues elettrici sgangherati, pattern di batteria geometrici e martellanti, sfuriate di distorsioni e soprattutto quel groove di basso torbido e irresistibile, cortesia di Mr. David Sims. Il pezzo più diretto ed efficace è "Nub": batteria tirata, giro di basso killer e le montagne russe della chitarra distorta suonata in slide, praticamente col suono di una motosega, tutto merito della chitarra in alluminio di Denison. Più teatrale, "Seasick" imita la fobia di morire annegati; immenso Yow nel trasmettere con la sua interpretazione un sentimento così irrazionale e incontrollato.
I nove brani - perfetti dal primo all'ultimo - sono molto omogenei tra loro, ma colmi di variazioni: blues elettrici sgangherati, pattern di batteria geometrici e martellanti, sfuriate di distorsioni e soprattutto quel groove di basso torbido e irresistibile, cortesia di Mr. David Sims. Il pezzo più diretto ed efficace è "Nub": batteria tirata, giro di basso killer e le montagne russe della chitarra distorta suonata in slide, praticamente col suono di una motosega, tutto merito della chitarra in alluminio di Denison. Più teatrale, "Seasick" imita la fobia di morire annegati; immenso Yow nel trasmettere con la sua interpretazione un sentimento così irrazionale e incontrollato.
 Altro gioiello è la drogatissima "Monkey Trick", forse il capolavoro dell'intera discografia dei Jesus Lizard. Il brano è estremamente cinematografico e sembra un susseguirsi di scene: prima una scarica di rumore, poi una melodia stridula e dissonante interrotta da un urlo lancinante nel bel mezzo di un crescendo. E' impossibile dare una descrizione dell'andamento generale del pezzo se non passo per passo, tante sono le situazioni cui si va incontro e i punti in cui si ritorna al centro di questo labirinto. Quel che è certo è che il livello compositivo della band è fuori dal comune.
Altro gioiello è la drogatissima "Monkey Trick", forse il capolavoro dell'intera discografia dei Jesus Lizard. Il brano è estremamente cinematografico e sembra un susseguirsi di scene: prima una scarica di rumore, poi una melodia stridula e dissonante interrotta da un urlo lancinante nel bel mezzo di un crescendo. E' impossibile dare una descrizione dell'andamento generale del pezzo se non passo per passo, tante sono le situazioni cui si va incontro e i punti in cui si ritorna al centro di questo labirinto. Quel che è certo è che il livello compositivo della band è fuori dal comune.
Dimostrazione di eclettismo e classe, "Karpis" è un country-rock nevrotico e urbano che fa da contorno a una storia di prigione; "Lady Shoes" si sposa invece con quell'immaginario horror-redneck di storie di follia nella provincia americana, sarà il basso incessante che pompa all'inverosimile fino alla sfuriata finale di Yow. Lo show si chiude con "Rodeo In Joliet", il brano più lungo, lento e desolato della raccolta. Il cantato è praticamente un ululato privo di grazia, così brutto ma così toccante nel dipingere uno scenario arido e senza vita.
 Terminato l'ascolto, il cuore batte ancora a mille, come dopo uno spavento terribile o una fatica. "Goat" è appunto un'esperienza repentina, inarrestabile e che non lascia un attimo per respirare, merito della sua natura divisa un tra un crudo iperrealismo nelle liriche e una dose immane di adrenalina nella musica.
Terminato l'ascolto, il cuore batte ancora a mille, come dopo uno spavento terribile o una fatica. "Goat" è appunto un'esperienza repentina, inarrestabile e che non lascia un attimo per respirare, merito della sua natura divisa un tra un crudo iperrealismo nelle liriche e una dose immane di adrenalina nella musica.

















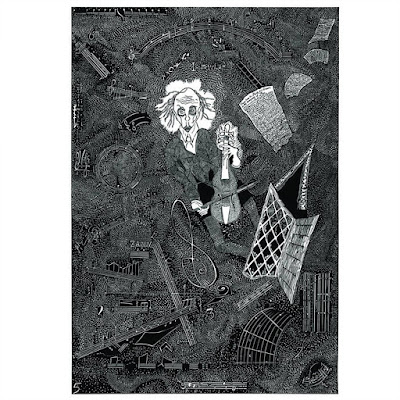


,-Ink-pen-on-paper,-14.5x21cm.-Photo-by-Ellie-Walmsley.jpg)