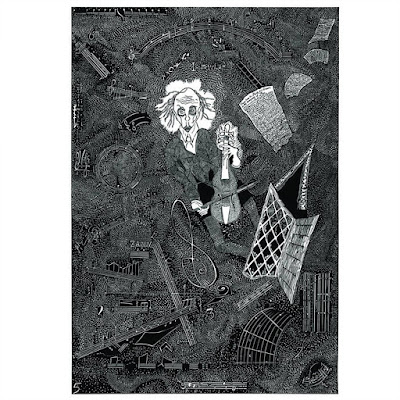domenica 15 ottobre 2023
Dischi nella tomba: Noir Dèsir - Des Visages Des Figures (2001)
L'11 Settembre 2001 è una data nel nostro immaginario collettivo; l'attentato alle Twin Towers che ha sconvolto i paesi occidentali e ne ha ridefinito gli assetti. 'Lo stesso giorno in Francia viene distribuito Des Visage Des Figure sesto è ultimo album dei Noir Dèsir.
Questo sarà il disco della consacrazione internazionale, vista l'improvvisa visibilità ottenuta dai Noir Dèsir entrati (e poi subito usciti) dal circuito Main Stream musicale. Il punto più alto della loro produzione artistica. Oltre un milione di copie vendute e un “Grammy Award” come miglior album rock francese del 2001. Partendo dalla seconda traccia “Le grand incendie” il disco diventa subito un presagio inquietante, il racconto in diretta di un’apocalisse, il del disfacimento della civiltà occidentale, la fotografia di una società malata di competizione e di economie selvaggie.
 Tutte le canzoni sono intrise da una atmostera cupa, desolata, stagnante di rabbia e malinconia. E' la poesia a farla da padrona, lo dimostra l'abilità compositiva di Cantant che tanto abilmente ne è l'interprete principale.
Tutte le canzoni sono intrise da una atmostera cupa, desolata, stagnante di rabbia e malinconia. E' la poesia a farla da padrona, lo dimostra l'abilità compositiva di Cantant che tanto abilmente ne è l'interprete principale.
I cinque anni passati dal precedente album hanno provocato una rivoluzione nello stile della band: un esempio concreto di tale cambiamento lo si può ascoltare in “Son style 1” e “Son style 2”, legata ad un punk rock veloce della prima, eterea e malferma la seconda, un incrocio tra Jeff Buckley e Thom Yorke. Riuscitissimo e commovente anche l’omaggio a Léo Ferré (“Des armes”), il cui testo esistenzialista ed anarcoide è stato musicato con reverenza dai Noir Désir, mentre “Le vent nous portera” con Manu Chao alla chitarra fornisce una profondità ed un ritmo ad una melodia indimenticabile.
 Dopo la meraviglia poetica di 'Bouquet de nerfs' arriva la terrificante "L'Europe": ventiquattro minuti in cui Cantat e Brigitte Fontaine declamano un vero e proprio pamphlet che non lascia scampo a niente e nessuno. Musicalmente vicina alle jam free-form più eccentriche degli anni '60, con un arsenale di fiati, percussioni, chitarre e quant'altro che si affollano gli uni sopra gli altri. Più che una canzone, un viaggio composto dalle atmosfere maudit marca Doors e da quelle metropolitane Velvet Underground. Politica, economia, stato sociale, tutta la civiltà occidentale viene messa sotto accusa attraverso uno dei testi più belli, visionari eppure realistici e impietosi che si siano mai sentiti.
Dopo la meraviglia poetica di 'Bouquet de nerfs' arriva la terrificante "L'Europe": ventiquattro minuti in cui Cantat e Brigitte Fontaine declamano un vero e proprio pamphlet che non lascia scampo a niente e nessuno. Musicalmente vicina alle jam free-form più eccentriche degli anni '60, con un arsenale di fiati, percussioni, chitarre e quant'altro che si affollano gli uni sopra gli altri. Più che una canzone, un viaggio composto dalle atmosfere maudit marca Doors e da quelle metropolitane Velvet Underground. Politica, economia, stato sociale, tutta la civiltà occidentale viene messa sotto accusa attraverso uno dei testi più belli, visionari eppure realistici e impietosi che si siano mai sentiti.
 |
giovedì 27 luglio 2023
"È solo la fine del mondo" - Xavier Dolan (2016)
E' da attribuire a un principio di sottrazione più che di espansione – contrariamente a quanto avviene di solito nell’adattamento di un testo teatrale per il cinema – la profonda stilizzazione con cui Xavier Dolan confeziona la messa in scena di Juste la fin du monde (1990) di Jean-Luc Lagarce. Considerata da molti il capolavoro dell’autore, morto di Aids a 38 anni nel 1995, la pièce racconta il ritorno a casa dopo 12 anni del giovane scrittore omosessuale Louis che intende preannunciare ai familiari la propria morte, con l’intento di dare un senso agli ultimi giorni della sua vita. Sesto lungometraggio di Xavier Dolan, premiato a Cannes con il Grand Prix nel 2016, È solo la fine del mondo non si discosta dal testo teatrale ma lo rielabora in un‘architettura di immagini claustrofobiche, incollate al volto dei personaggi, ritratti in primissimi piani che debordano dallo schermo. La parola del testo originale, frammentata e complessa, non si tramuta semplicemente in linguaggio verbale ma assume una valenza sonora (con dialoghi urlati, ridondanti, ossessivi) e visiva (attraverso l’uso esclusivo del viso in lunghe sequenze di campi e controcampi).
Le immagini consistono in dettagli espressivi dei volti e in flashback di ricordi e visioni spesso montati in forma di ralenti ed esaltati dalla musica. I personaggi (la madre, il fratello, la sorella e la cognata di Louis) sono intrappolati in un luogo quasi senza tempo, quello dell’infanzia e della nostalgia, a cui il giovane fa ritorno. Straniati dal ritmo incalzante di conversazioni isteriche e dall’ossessivo pedinamento che la macchina da presa opera sui volti e sugli occhi, appaiono come fantasmi di se stessi, teste di fantocci svuotati della propria anima, proiezioni e simulacri dell’incomunicabilità affettiva.
Odio e amore, gelosia ed affetto si impongono come sentimenti ingovernabili, rivelati dagli sguardi e dalla mimica facciale ma celati dalle parole, impronunciabili, a denunciare il netto distacco fra il pensiero che ogni personaggio ha di sé e degli altri e la capacità di esternarlo. Sebbene sia centrale, come nella precedente filmografia di Dolan, il rapporto con la figura materna, il conflitto principale, in questo burrascoso ritratto di famiglia in un interno, è tra i due fratelli: mentre Louis è riuscito ad abbandonare il nido familiare per seguire le sue aspirazioni e costruirsi una vita autonoma ma percepisce il senso costante dell’abbandono che diviene il suo rimorso e il suo malessere interiore, Antoine non ne è stato capace e questo alimenta la rabbia e il rancore nei confronti del fratello.
Da un lato teme la sua omosessualità e lo disprezza, dall’altro ne invidia la libertà creativa. Paradossalmente, l’unico strumento possibile della comunicazione familiare è il silenzio, l’isolamento muto, riservato e schivo, con cui Louis osserva ad ascolta, mentre l’eloquio ostinato, violento e verboso di Antoine materializza il vuoto della comunicazione affettiva. La parola evoca dunque la negazione dei sentimenti e la loro autocensura. Non è l’assenza di sentimenti ad essere incomunicabile ma il loro eccesso. Le emozioni dei personaggi sono talmente profonde che non la parola, solo il silenzio riesce ad esprimerle. Proprio per questo, dopo il momento del commiato finale, che chiude la scena su un’impossibile armonia familiare, Louis è nuovamente solo, nell’ingresso dov’era stato accolto inizialmente dalla famiglia, ormai un estraneo fra gli spettri della memoria.
Dischi nella tomba: L'enfance Rouge - Trapani-Halq al Waady (2008)
Il Sesto album per Il terzetto italo-francese è un lavoro affascinante, maturo e spiazzante. Noise-rock monolitico e suoni mediterranei si incontrano in un'apocalisse al confine tra due mondi: il grigiore metropolitano di Bästard e Ulan Bator e il misticismo antico della musica nordafricana.
Il disco è il manifesto di una contro-colonizzazione sonora che si consuma in una infuocata danza apolide sospesa tra asperità (noise, post-rock) e melodie e atmosfere di matrice magrebina realizzate da un gruppo di musicisti tunisini capitanati dal maestro Mohamed Abid virtuoso di oud (una sorta di liuto), all’interno dell’Orchestra Nazionale de La Rachidia, che trova la giusta chiave di lettura (tramite misurati interventi vocali, arpeggi minimali, fiati e percussioni che allargano lo spettro sonoro) agli spasmi rumoristi di Cambuzat e soci.
Niente a che vedere col turismo musicale più becero: l'iniziale "Otranto" chiarisce da subito che "Trapani-Halq al Waady" affianca oud e sciabolate elettriche, forme tradizionali e spleen contemporaneo in un sound lucido, coeso e lontano dal terzomondismo.
Ieratica, Chiara Locardi declama versi torvi e disincantati sugli 11/8 di "Ras et Ahmar"; chitarre laceranti e vapori esotici avvolgono un racconto a cavallo fra tempi e luoghi.
La frontiera, il fascino atavico del remoto: elementi cardine dell'immaginario Enfance Rouge, non sono mai stati evocativi e tangibili quanto negli arabeschi flautistici di "Ana Lastu Amrikyyan", martoriati di colate noise, o nei contorcimenti vocali che chiudono "Hurricane Lily".
Quando è François Cambuzat a prendere il microfono, i toni si fanno ancora più torpidi. "Tombeau pour New York" opprime, soffoca: clangori, incedere marziale e un basso pachidermico la cui tensione letargica pervade l'intero album. Poca, pochissima la luce, una fiamma moribonda quella che riscalda la placidità tunisina di "Vendicatori" o "Petite-mort".
Cinico, graffiante, eppure denso di passione, sensibilità, poesia, "Trapani-Halq al Waady" è più che un disco una città, una porta tra continenti. Unica, in tutti i suoi contrasti e chiaroscuri.
"Piuttosto che la giustizia preferiamo il caos"
venerdì 7 aprile 2023
Dischi nella tomba: 24 Grana - K-album (2001)
Napoli, anni 90, periferia Est della zona industriale, lontano dalle sfavillanti luci del lungomare o dal rassicurante salotto del centro storico. Officina 99 è un centro sociale autogestito, occupato da un gruppo di studenti e militanti ai quali a inizio maggio di quell’anno era fallito un precedente tentativo di occupazione dell’ex scuola Falco, che si trova al numero 99 di via Emanuele Gianturco. Ci riprovano il 22 settembre: al civico 101 si trova un’officina abbandonata, stavolta il tentativo va a buon fine. Il nome del centro è l’unione tra il fabbricato (Officina) e il numero riferito alla scuola, oggetto dell’occupazione precedente (99).
Da Officina 99 parte la nuova era dell’underground partenopeo. All’interno di quelle sale c’è cinema, teatro, danza, un laboratorio sociale e politico, diviso tra il doposcuola ai bambini del quartiere, l’insegnamento della lingua italiana agli extracomunitari e le vertenze finalizzate al miglioramento dell’area urbana circostante. E poi c’è la musica: le nuove tendenze hanno le mille parole del rap, i suoni elettronici della dub, l’elettronica, il rock indipendente e tanto altro.

All’ombra di Officina 99, a metà decennio muovono i primi passi quattro ragazzi che hanno incrociato i loro destini a Valle Agricola, un paesino di 800 anime in provincia di Caserta. Loro sono Francesco Di Bella (voce e chitarra), Armando Cotugno (basso), Giuseppe Fontanella (chitarra solista) e Renato Minale (batteria). La loro band si chiama 24 Grana, dal nome di una moneta di scarso valore risalente all’epoca aragonese. I quattro propongono un misto di dub, rock ed elettronica, di stampo chiaramente militante.
Dagli esordi di “Loop” (1997) al salto di qualità spiccato con “Metaversus” (1999), si arriva nel 2001 a “K-album”un concept album costruito tutto intorno alla lettera k, intesa come key, la chiave che apre le porte del futuro. Anche l’artwork fornisce un’informazione importante: la copertina è incolore, una grande lettera K a tutto campo, che se ruotata in senso orario rappresenta lo schema iniziale per un disegno in prospettiva. Da questo punto di vista, è come se i 24 Grana volessero comunicare di aver gettato le basi per la musica di domani.
Le melodie in dialetto, talvolta riprese dal repertorio storico della canzone napoletana (Lu Cardillo), viaggiano verso la consacrazione nazionale. Le ormai tipiche atmosfere dub-rock in “K-album” si mischiano ad un songwriting che lentamente perde quella matrice di folk profondo e primordiale. Di Bella canta maggiormente in italiano, ma il suo non è un incedere vocale che segue modelli, stili e inclinazioni già visti.
 L’inizio – con "Pikkola kanzone per k" – è già evocativo dello spirito del disco, e gioca su una bilanciata contrapposizione elettroacustica. E’ subito momento di ballad, ce ne sono tre, tutte diverse tra loro. Dai canoni classici di "E kose ka spakkano" si passa all’atmosfera latineggiante di Kanzone doce; il triangolo si chiude con la malinconica e militantelitania di "Kanzone su un detenuto politico" insieme a "Kanzoneanarkika".
L’inizio – con "Pikkola kanzone per k" – è già evocativo dello spirito del disco, e gioca su una bilanciata contrapposizione elettroacustica. E’ subito momento di ballad, ce ne sono tre, tutte diverse tra loro. Dai canoni classici di "E kose ka spakkano" si passa all’atmosfera latineggiante di Kanzone doce; il triangolo si chiude con la malinconica e militantelitania di "Kanzone su un detenuto politico" insieme a "Kanzoneanarkika".
Con "Kanzone su Londra" si cambia per un attimo registro: la voce stentorea di Di Bella si adagia su sonorità new wave in tipico stile british, mentre il lampo, chiaro ed evidente, di cosa saranno i prossimi 24 Grana si ha con "Kanzone del pisello". Il punto più alto del disco però è "Kevlar", dove al rumore della pioggia in sottofondo si accompagnano voce, piano e un riuscito mix di riff e synth. La degna chiusura si ha con la strumentale "Kanzone del fumo", dove si mescolano tutti gli elementi elettronici e acustici sentiti fino a quel momento: è il saluto dei 24 Grana, un arrivederci intriso di dolcezza autentica.
“K-album” rappresenta la presa di coscienza definitiva della vera fisionomia artistica della band napoletana ed il loro punto massimo dell'intera carriera artistica.
giovedì 26 gennaio 2023
Dischi nella tomba: The Jesus Lizard - Goat (1991)
Uno dei capolavori degli anni novanta è "Goat", il secondo Lp dei Jesus Lizard di Chicago. Un lavoro che merita di essere ricordato come uno dei dischi più viscerali di tutti i tempi, anche a prescindere dal peso non indifferente che ha esercitato sulla scena post-hardcore e noise.
Noise, ma a modo loro. Due dei quattro si erano fatti le ossa negli Scratch Acid, e ciò è contato molto nella definizione del suono dei Jesus Lizard, che con le canzoni di "Goat" portarono ai massimi livelli la fusione di melodie roots e rumorismo noise-rock, sia nella musica che nell'immaginario. Qualcosa di simile l'aveva fatto Steve Albini nei suoi testi, mentre per quanto riguarda la musica il la l'avevano dato dieci anni prima i Birthday Party, col loro post-punk blueseggiante. I Jesus Lizard però si spinsero oltre, generando un caso alquanto unico nel rock.
 Tre strumentisti eccezionali e peculiari suonano ritmiche e tessiture intricatissime. Poi, il più sgraziato dei cantanti gode nello scombinare tutto. E' David Yow, vero maestro nell'usare la sua voce tecnicamente scarsa in modo espressionista e poco ortodosso. Urla, ringhi, conati, versacci, ogni mezzo è lecito per suscitare disagio in chi ascolta, shockarlo, trasmettergli con crudo cinismo quel senso di degrado, violenza psicologica e disaffezione. Ma ogni cosa è studiata al suo posto con chirurgica precisione, dai ragli di Yow ai tempi dispari della batteria di Mac MacNeilly e, dulcis in fundo, l'ottima produzione di Steve Albini rende il tutto ancora più claustrofobico e dannatamente perfetto.
Tre strumentisti eccezionali e peculiari suonano ritmiche e tessiture intricatissime. Poi, il più sgraziato dei cantanti gode nello scombinare tutto. E' David Yow, vero maestro nell'usare la sua voce tecnicamente scarsa in modo espressionista e poco ortodosso. Urla, ringhi, conati, versacci, ogni mezzo è lecito per suscitare disagio in chi ascolta, shockarlo, trasmettergli con crudo cinismo quel senso di degrado, violenza psicologica e disaffezione. Ma ogni cosa è studiata al suo posto con chirurgica precisione, dai ragli di Yow ai tempi dispari della batteria di Mac MacNeilly e, dulcis in fundo, l'ottima produzione di Steve Albini rende il tutto ancora più claustrofobico e dannatamente perfetto.
 I nove brani - perfetti dal primo all'ultimo - sono molto omogenei tra loro, ma colmi di variazioni: blues elettrici sgangherati, pattern di batteria geometrici e martellanti, sfuriate di distorsioni e soprattutto quel groove di basso torbido e irresistibile, cortesia di Mr. David Sims. Il pezzo più diretto ed efficace è "Nub": batteria tirata, giro di basso killer e le montagne russe della chitarra distorta suonata in slide, praticamente col suono di una motosega, tutto merito della chitarra in alluminio di Denison. Più teatrale, "Seasick" imita la fobia di morire annegati; immenso Yow nel trasmettere con la sua interpretazione un sentimento così irrazionale e incontrollato.
I nove brani - perfetti dal primo all'ultimo - sono molto omogenei tra loro, ma colmi di variazioni: blues elettrici sgangherati, pattern di batteria geometrici e martellanti, sfuriate di distorsioni e soprattutto quel groove di basso torbido e irresistibile, cortesia di Mr. David Sims. Il pezzo più diretto ed efficace è "Nub": batteria tirata, giro di basso killer e le montagne russe della chitarra distorta suonata in slide, praticamente col suono di una motosega, tutto merito della chitarra in alluminio di Denison. Più teatrale, "Seasick" imita la fobia di morire annegati; immenso Yow nel trasmettere con la sua interpretazione un sentimento così irrazionale e incontrollato.
 Altro gioiello è la drogatissima "Monkey Trick", forse il capolavoro dell'intera discografia dei Jesus Lizard. Il brano è estremamente cinematografico e sembra un susseguirsi di scene: prima una scarica di rumore, poi una melodia stridula e dissonante interrotta da un urlo lancinante nel bel mezzo di un crescendo. E' impossibile dare una descrizione dell'andamento generale del pezzo se non passo per passo, tante sono le situazioni cui si va incontro e i punti in cui si ritorna al centro di questo labirinto. Quel che è certo è che il livello compositivo della band è fuori dal comune.
Altro gioiello è la drogatissima "Monkey Trick", forse il capolavoro dell'intera discografia dei Jesus Lizard. Il brano è estremamente cinematografico e sembra un susseguirsi di scene: prima una scarica di rumore, poi una melodia stridula e dissonante interrotta da un urlo lancinante nel bel mezzo di un crescendo. E' impossibile dare una descrizione dell'andamento generale del pezzo se non passo per passo, tante sono le situazioni cui si va incontro e i punti in cui si ritorna al centro di questo labirinto. Quel che è certo è che il livello compositivo della band è fuori dal comune.
Dimostrazione di eclettismo e classe, "Karpis" è un country-rock nevrotico e urbano che fa da contorno a una storia di prigione; "Lady Shoes" si sposa invece con quell'immaginario horror-redneck di storie di follia nella provincia americana, sarà il basso incessante che pompa all'inverosimile fino alla sfuriata finale di Yow. Lo show si chiude con "Rodeo In Joliet", il brano più lungo, lento e desolato della raccolta. Il cantato è praticamente un ululato privo di grazia, così brutto ma così toccante nel dipingere uno scenario arido e senza vita.
 Terminato l'ascolto, il cuore batte ancora a mille, come dopo uno spavento terribile o una fatica. "Goat" è appunto un'esperienza repentina, inarrestabile e che non lascia un attimo per respirare, merito della sua natura divisa un tra un crudo iperrealismo nelle liriche e una dose immane di adrenalina nella musica.
Terminato l'ascolto, il cuore batte ancora a mille, come dopo uno spavento terribile o una fatica. "Goat" è appunto un'esperienza repentina, inarrestabile e che non lascia un attimo per respirare, merito della sua natura divisa un tra un crudo iperrealismo nelle liriche e una dose immane di adrenalina nella musica.
mercoledì 25 gennaio 2023
Repulsion - Roman Polanski (1965)
L'angosciante inquadratura di un occhio sbarrato apre il secondo lungometraggio di Roman Polanski, Repulsion, un viaggio allucinato nella sfera psichica di una donna incantevole e disturbata. Carol (Catherine Deneuve) lavora in un salone di bellezza londinese, una sorta di tempio della femminilità affollato da giovani in divisa e anziane mummificate. Polański pedina la donna nel traffico frenetico di una città in costruzione dove ogni sguardo maschile viene percepito come ostile e mostruoso. L’unico rifugio da queste continue minacce sembra essere l’appartamento che condivide con la sorella (Yvonne Furneaux), una donna dissimile da ogni punto di vista.
 Qui Carol si sente al sicuro e a proprio agio, eccetto per la presenza invasiva del cognato. Il rasoio nel bagno, eterno simbolo paterno e maschile, unito ai continui gemiti sessuali notturni, alterano la dimensione casalinga. Nel momento in cui la coppia decide di partire per un viaggio di piacere in Italia, la giovane resta sola con i suoi demoni.
Qui Carol si sente al sicuro e a proprio agio, eccetto per la presenza invasiva del cognato. Il rasoio nel bagno, eterno simbolo paterno e maschile, unito ai continui gemiti sessuali notturni, alterano la dimensione casalinga. Nel momento in cui la coppia decide di partire per un viaggio di piacere in Italia, la giovane resta sola con i suoi demoni.
Carol vuole essere libera di non avere niente a che fare con nessun tipo di individuo di sesso maschile, per il quale prova un forte senso di disgusto e repulsione. Anche se tenta di creare una bolla di protezione intorno a sé, tutto il suo mondo è comunque pervaso da riferimenti maschili. In una società dove sembra sia obbligatorio avere un uomo accanto a sé, o perlomeno desiderare di averlo, Carol osserva sognante il convento fuori dalla sua finestra, un ambiente puro e protetto.
A poco a poco inizia una lenta discesa nella folle mente allucinata della donna, un cambio di registro che Polanski racchiude nelle quattro mura dell’appartamento. Dalla barca di Il coltello nell’acqua ai successivi Rosemary’s Baby e L’inquilino del terzo piano, il regista riuscirà sempre a riverberare perfettamente il malessere mentale in uno spazio claustrofobico e circoscritto.
La fotografia contrastata di Gilbert Taylor (Il dottor Stranamore, Guerre Stellari) unita al nutrito ecosistema sonoro fatto di ticchettii e rumori di passi alternati a lunghi silenzi, creano un atmosfera onirica e surreale. I volti iniziano a deformarsi nel riflesso di un bollitore o nello spioncino della porta, mentre alcune crepe si aprono nelle mura di casa.
 Nel suo primo film anglofono, Roman Polanski costruisce una dimensione ansiogena da horror psicologico, in cui la camera a spalla e il grandangolo trascinano lo spettatore dentro la percezione instabile della protagonista, contrariamente alla consuetudine hitchcockiana.
Nel suo primo film anglofono, Roman Polanski costruisce una dimensione ansiogena da horror psicologico, in cui la camera a spalla e il grandangolo trascinano lo spettatore dentro la percezione instabile della protagonista, contrariamente alla consuetudine hitchcockiana.
Immagini come quella delle braccia maschili nel corridoio o delle inquietanti crepe aperte nelle mura sono tuttora aggrappate all’immaginario cinematografico collettivo.
Un film splendido, efficace come pochi nella creazione di suspense e angoscia. Superba e bellissima la Deneuve seguita ossessivamente dalla camera assieme ai suoi silenzi e alle sue paure, splendida anche la colonna sonora firmata dal valoroso batterista jazz Chico Hamilton. Polanski così cattura lo spettatore facendolo precipitare, insieme alla sua protagonista, nel baratro della follia umana.
venerdì 20 gennaio 2023
Dischi nella tomba: This Heat - Deceit (1981)
I This Heat erano assoluti outsider. Nacquero a ridosso della rivoluzione punk e ne condivisero molti aspetti: il suono animalesco, l'ostilità alla tecnica strumentale fine a se stessa, il culto del do-it-yourself, la volontà di riportare la musica sulla terra, nelle città, al centro delle situazioni politiche e sociali reali. Con le band dell'ondata progressiva, però, avevano almeno altrettanti punti di contatto: la perizia esecutiva di Hayward, la passione per gli intrecci ritmici fuori dagli schemi e le composizioni segmentate, la radicale avversione al blues, l'ambizione fortemente sperimentale, la cura dei dettagli. La loro natura duplice rappresentava un ponte seminascosto tra le frange estreme della galassia progressive - kraut-rock, Canterbury sound, Rock In Opposition - e il post-punk più urbano e intellettuale, legato al marxismo, al femminismo, al post-strutturalismo (dai Gang Of Four al Pop Group, passando per le Raincoats e i primi Scritti Politti).

"Deceit" è frutto di un'era di transizione, non solo musicalmente: uscì nel 1981, agli albori della "dottrina Reagan". È sostanzialmente un concept sull'apocalisse nucleare, permeato dello stesso umore plumbeo che la band respirava in quell'epoca ("Eravamo convinti che saremmo morti tutti quanti nel giro di tre anni", avrebbe spiegato Hayward tempo dopo). A incutere ancora maggior timore era il senso di torpore percepito nella società, incapace di vedere la trama di inganni tessuta dal potere e dai mass media.
La traccia che apre il disco è proprio un invito al sonno dal paradigmatico titolo "Sleep", sospesa tra ozio e disillusione. Le cose cambiano radicalmente con "Paper Hats", da subito sghembissima e inquietante: la voce è lenta e lamentosa, poi strisciata e angosciosa; la chitarra è un groviglio sferragliante ripetuto senza variazione. All'apice del fragore, si giunge improvvisamente in una palude di geometria ritmica in stile Can - uno schema in 11/4 ipnotico e imprendibile, che sembra fermare il tempo.
 Un commentatore d'eccezione svelò il segreto dietro ad architetture così astratte e calcolate: dopo aver assistito a una prova della band, Fred Frith degli Henry Cow ironizzò che i tre This Heat avessero passato tutto il tempo a litigare in termini astrusi su come la musica dovesse suonare. Hayward, Bullen e Williams passarono tre settimane a discutere dei pezzi in questi termini, per poi concretizzarli in pochissimi giorni una volta imbracciati gli strumenti. In questo modo, riuscivano a unire lucidità e istinto improvvisativo, creando musica che non fosse veramente "composta", ma il cui andamento fosse previsto nel dettaglio.
Un commentatore d'eccezione svelò il segreto dietro ad architetture così astratte e calcolate: dopo aver assistito a una prova della band, Fred Frith degli Henry Cow ironizzò che i tre This Heat avessero passato tutto il tempo a litigare in termini astrusi su come la musica dovesse suonare. Hayward, Bullen e Williams passarono tre settimane a discutere dei pezzi in questi termini, per poi concretizzarli in pochissimi giorni una volta imbracciati gli strumenti. In questo modo, riuscivano a unire lucidità e istinto improvvisativo, creando musica che non fosse veramente "composta", ma il cui andamento fosse previsto nel dettaglio.
Un altro contributo fondamentale per rendere "strutturato" materiale nato improvvisando fu dato dalla tape manipulation, il lavoro diretto sui nastri magnetici per far confluire in un unico brano musica registrata in momenti diversi. I This Heat trafficarono con questo genere di tecniche fin dai loro primissimi momenti, e già il loro primo album era costituito in buona parte da loop vari sottoposti a taglia e cuci. Nessuno al tempo era abituato a cose simili. Un trucchetto molto amato dalla band era quello di entrare in un loop strumentale, tirarlo avanti per un po', dando il tempo al fonico di registrarlo, per poi smettere di suonare e uscire dal palco, lasciando il pubblico sgomento davanti alla musica che continuava a uscire dagli amplificatori.
 Proprio con "S.P.Q.R." il disco giunge al nucleo del suo tema centrale, la cultura del terrore permanente. Questa è ricondotta all'Impero Romano, ma l'ammissione "We are all Romans" la riproietta nel presente.
Proprio con "S.P.Q.R." il disco giunge al nucleo del suo tema centrale, la cultura del terrore permanente. Questa è ricondotta all'Impero Romano, ma l'ammissione "We are all Romans" la riproietta nel presente.
Con "Makeshift Swahili" chitarra e basso menano fendenti obliqui, si incrociano con la batteria e tracciano gli incastri più spigolosi. La voce è un ruggito a un passo dal growl che sarà del metal estremo, e il bordone tenuto dall'organo rende il clima ancora più teso e inquietante. I racconti narrano che nei concerti Williams appoggiasse per terra una tastiera avuta in prestito da Dave Jarrett dei Quiet Sun e la percuotesse selvaggiamente, arrivando perfino a sanguinare, non per irriverenza punk, ma perché "era l'unico modo per ricavarne il suono adatto".
 Se ciò non basta a render conto della fama di "band più violenta mai sentita", guadagnata già dopo pochi concerti, la parte finale di "Makeshift Swahili" fa svanire ogni dubbio. L'inferno tradotto in musica.
Se ciò non basta a render conto della fama di "band più violenta mai sentita", guadagnata già dopo pochi concerti, la parte finale di "Makeshift Swahili" fa svanire ogni dubbio. L'inferno tradotto in musica.
Tutte le anime di "Deceit" convergono in "A New Kind Of Water", che è anche la concretizzazione più esplicita dell'umore mefitico che permea l'album. Il canto è inizialmente un lamento folk, ma con un crescendo vertiginoso muta nell'episodio più melodico del disco: un assalto corale all'unisono, epico e disperato, alimentato da un'angosciosa disillusione. Il testo riveste del sarcasmo più nero i presagi apocalittici che aleggiano su tutto il disco: quando l'industrializzazione e l'energia nucleare avranno reso il pianeta inabitabile, quando la corsa alla ricchezza avrà portato all'assoluta povertà, tutto quello che servirà sarà "un nuovo tipo di acqua, un nuovo modo di respirare".
 I This Heat vedevano in questa illusione la condanna della loro epoca: una società ipnotizzata dall'inganno (in inglese deceit, per l'appunto), incapace sia di vedere la minaccia che di reagire. Ci furono molte discussioni nella band se il testo dovesse essere in seconda o terza persona plurale oppure in prima - era la differenza che passava tra un atto d'accusa e una disincantata ammissione di colpa. Prevalse la seconda visione: non era più possibile distinguere tra bianchi a neri, tra individui parte del problema e altri parte della soluzione. La continua necessità di un "mostro" esterno a cui imputare le colpe era parte del problema.
I This Heat vedevano in questa illusione la condanna della loro epoca: una società ipnotizzata dall'inganno (in inglese deceit, per l'appunto), incapace sia di vedere la minaccia che di reagire. Ci furono molte discussioni nella band se il testo dovesse essere in seconda o terza persona plurale oppure in prima - era la differenza che passava tra un atto d'accusa e una disincantata ammissione di colpa. Prevalse la seconda visione: non era più possibile distinguere tra bianchi a neri, tra individui parte del problema e altri parte della soluzione. La continua necessità di un "mostro" esterno a cui imputare le colpe era parte del problema.La copertina inizialmente immaginata per l'album doveva raffigurare il gruppo intento a suonare, con gli strumenti connessi direttamente a una centrale nucleare. Si optò invece per un collage espressionistico in cui funghi atomici, mappe di arsenali nucleari, volti di Reagan e Breznev assumono la forma di una maschera scarnificata e urlante.
Il requiem di un'intera civiltà. Della nostra civiltà. Una batteria che spara colpi di pistola in fronte a quella maschera di rifiuti che sorride beffardamante in copertina. Quella maschera l'abbiamo indossata tutti, anche solo per un momento, e quella chitarra che mette tanta paura non è altro che il suono delle nostre menzogne.
venerdì 13 gennaio 2023
Dischi nella tomba: Rudimentary peni - Cacophony (1988)
In retrospettiva il gruppo piu` importante del punk estremista inglese e` forse quello dei Rudimentary Peni. Capitanato da un vero e proprio ossesso, Nick Blinko, questo trio di Londra (Jon Greville alla batteria e Grant Matthews al basso) si distinse dalla massa dei gruppi hardcore non tanto per la violenza e la brevita` dei propri brani (peraltro davvero difficili da battere), ma per l'assoluta essenzialita` della loro musica, per la varieta` dei ritmi e per un incidere generalmente piu` melodico della media.

I primi due EP costituiscono un assalto frontale senza molti rivali. Rudimentary Peni (Outer Himalayan), registrato nel 1981, contiene ben dodici pezzi, uno piu` fulmineo e assordante dell'altro In anthem grezzi e virulenti come Media Person, B-Ward, Hearse e Play Blinko accelera maniacalmente il "ramalama" di Joey Ramone e le invettive di Johnny Rotten e li deforma con le sue particolari bizzarrie gutturali, a meta` fra un licantropo in calore e uno sciamano pellerossa. I Rudimentiry Peni non sprecano un secondo di musica, e questo puo` dare l'impressione di una certa monotonia, ma in realta` c'e` molta piu` varieta` di quanto sembri, e in brani come Teenage Time Killer e Him Hymn e` la chitarra a movimentare l'armonia con riff insoliti.
E ogni pezzo ha una sua precisa identita`. Per tutto il disco continua ad emergere il tema di un esoterismo "nero" (in Gardener tentano persino una specie di raga-punk).
 Un anno dopo il secondo EP, Farce (Crass), colpi` con la stessa efferatezza: Sacrifice e` uno dei rock and roll piu` esagitati di sempre, doppiato da Cosmic Plague, Il ritmo e` talmente vorticoso che talvolta Blinko deve urlare senza prendere fiato, con effetti vocali curiosi. L'esoterismo del disco precedente e` diventato un "malessere cosmico" all'insegna di un pervicace ateismo ("God Is nothing more than an obsessive lie" oppure "Death has begun and Jesus loves no one") e talvolta degenera in filastrocche ermetiche come quella di Farce o in deliri ossessivi psicopatici come Zero Again.
Un anno dopo il secondo EP, Farce (Crass), colpi` con la stessa efferatezza: Sacrifice e` uno dei rock and roll piu` esagitati di sempre, doppiato da Cosmic Plague, Il ritmo e` talmente vorticoso che talvolta Blinko deve urlare senza prendere fiato, con effetti vocali curiosi. L'esoterismo del disco precedente e` diventato un "malessere cosmico" all'insegna di un pervicace ateismo ("God Is nothing more than an obsessive lie" oppure "Death has begun and Jesus loves no one") e talvolta degenera in filastrocche ermetiche come quella di Farce o in deliri ossessivi psicopatici come Zero Again.
Death Church (Corpus Christi, 1983) compi` un ulteriore passo in avanti, cementando la reputazione dei Rudimentary Peni con una serie di brani improntati a un bislacco e blasfemo black humour (Vampire State Building, Alice Crucifies The Paedophiles).
,-Ink-pen-on-paper,-14.5x21cm.-Photo-by-Ellie-Walmsley.jpg) I Rudimentary Peni continuarono a operare nell'underground, riuscendo raramente a registrare dischi. Ma ogni volta si tratto` di un fulmine a ciel sereno. E` il caso del loro capolavoro, Cacophony (Outer Himalayan, 1987), la loro opera piu` radicale e una delle piu` radicali del punk-rock britannico di sempre. Portando all'esasperazione il loro metodo frammentario, i titoli della versione originale erano ben cinquanta. Molti sono soltanto degli spunti, per quanto geniali (vedi l'inno gotico di Sarcophagus), e spesso delle bizzarrie canore a ritmo marziale (come gli ansimi pulsanti di Dead Loved o il conciliabolo di American Anglophile), ma altri risultano molto piu` musicali di qualunque altra cosa avessero mai fatto. Qualche brano impiega delle melodie regolari e in particolare i brani strumentali mettono in pista delle singolari "fusion" di Sonic Youth, Public Image Ltd, Joy Division (soprattutto Evil Clergyman) e finanche di "grunge" (Brown Jenkin).
I Rudimentary Peni continuarono a operare nell'underground, riuscendo raramente a registrare dischi. Ma ogni volta si tratto` di un fulmine a ciel sereno. E` il caso del loro capolavoro, Cacophony (Outer Himalayan, 1987), la loro opera piu` radicale e una delle piu` radicali del punk-rock britannico di sempre. Portando all'esasperazione il loro metodo frammentario, i titoli della versione originale erano ben cinquanta. Molti sono soltanto degli spunti, per quanto geniali (vedi l'inno gotico di Sarcophagus), e spesso delle bizzarrie canore a ritmo marziale (come gli ansimi pulsanti di Dead Loved o il conciliabolo di American Anglophile), ma altri risultano molto piu` musicali di qualunque altra cosa avessero mai fatto. Qualche brano impiega delle melodie regolari e in particolare i brani strumentali mettono in pista delle singolari "fusion" di Sonic Youth, Public Image Ltd, Joy Division (soprattutto Evil Clergyman) e finanche di "grunge" (Brown Jenkin).
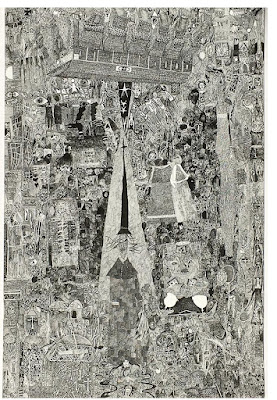 Che il punkrock sia sempre in agguato lo dimostra l'epilettica
Crazed Couplet, in cui una voce blatera in un registro da gargarismo
mentre l'altra batte il ritmo con grida forsennate. Ma a dominare il
disco e` un tono farsesco, che fa rivivere la follia "patafisica" dei
Pere Ubu nel grottesco balletto di Periwig Power e la pantomima
espressionista dei Residents nell'excursus esotico di Beyond The
Tanarian Hills; per non parlare di Beefheart, il cui bluesrock lunatico
ispira il pow-wow puerile di The Only Child e il rockabilly lascivo di
Lovecraft Baby. Cocophony e` in effetti un'operetta da vaudeville, ma di
un vaudeville "nero", una serie di scene di un magniloquente Grand
Guignol che traboccano di black humour. Cacophony e` in effetti un po'
l'Unnagumma o il Trout Mask Replica del punk britannico.
Che il punkrock sia sempre in agguato lo dimostra l'epilettica
Crazed Couplet, in cui una voce blatera in un registro da gargarismo
mentre l'altra batte il ritmo con grida forsennate. Ma a dominare il
disco e` un tono farsesco, che fa rivivere la follia "patafisica" dei
Pere Ubu nel grottesco balletto di Periwig Power e la pantomima
espressionista dei Residents nell'excursus esotico di Beyond The
Tanarian Hills; per non parlare di Beefheart, il cui bluesrock lunatico
ispira il pow-wow puerile di The Only Child e il rockabilly lascivo di
Lovecraft Baby. Cocophony e` in effetti un'operetta da vaudeville, ma di
un vaudeville "nero", una serie di scene di un magniloquente Grand
Guignol che traboccano di black humour. Cacophony e` in effetti un po'
l'Unnagumma o il Trout Mask Replica del punk britannico.